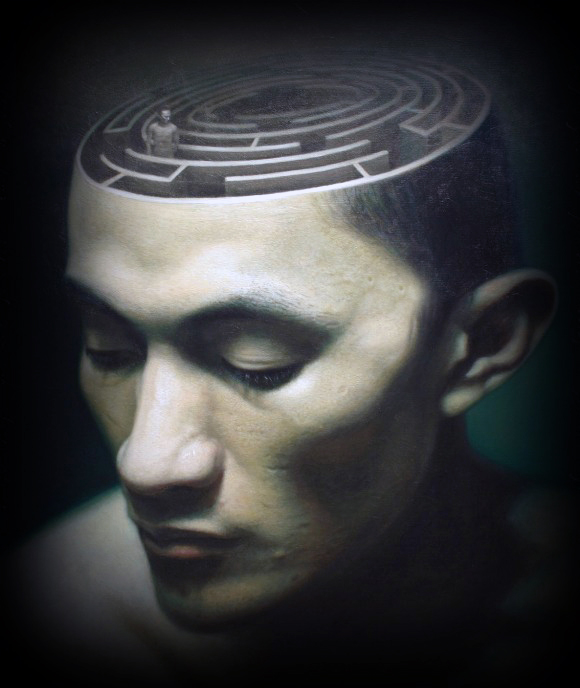
LA PSICOTERAPIA COME NARRAZIONE
Il ruolo del costruttivismo
Come probabilmente tende già ad emergere da quanto detto sinora, in questa impostazione è ovvio che “psicoterapia” – intesa come momento di riscrittura di una storia – non può essere considerata come “qualcosa” di esistente obbiettivamente e da somministrare come tale al “paziente”.
In primis, perché in tale prospettiva quelle che noi definiamo “scienze” non utilizzano l’obiettività per convalidare le proprie asserzioni (Maturana, 1997), perché la verità scientifica è sempre una descrizione della prassi dello sperimentatore (Maturana, in Watzlawick e Krieg, 1998), e dunque non esiste una “psicoterapia” che abbia una chiave per l’accesso ad essa. Ma soprattutto perché se “la scienza non è un modo per rivelare una realtà indipendente, ma un modo per costruire una realtà particolare vincolata dalle stesse condizioni che costituiscono l’osservatore come essere umano” (H. Maturana, 1993 pag. 16), fare psicoterapia significa creare regole condivise per nuovi spazi relazionali entro cui esperire nuovi modi di esperire ciò che definiamo il dominio del nostro spazio psicologico.
Nella prospettiva della VMT – dunque – la terapia è tale in quanto è un narrare, cioè un consapevolizzare una possibilità di riscrittura: ed è dunque un narrare in quanto è terapia.
E’ quindi un percorso che permette di esperire le possibilità di costruire (nello spazio delle relazioni) nuove via alla propria identità e alla propria realtà: processi questi che solo apparentemente sembrano differenti fra loro, e che vengono invece esperiti – nella VMT – allo stesso tempo e come qualità emergente del gruppo. Da questo punto di vista, la partecipazione ad un gruppo di VMT è implicitamente la partecipazione ad un gruppo che fa psicoterapia discutendo la psicoterapia, dal momento che essa emerge come dimensione autoreferenziale del contesto che la definisce come tale.
Di fatto, una parte importante del processo psicoterapico implicito nella VMT risiede così nel discutere la definizione stessa di “psicoterapia”, rendendo cioè in qualche modo esperibile che le asserzioni fatte in nome della scienza, e dunque della psicoterapia, non vengono convalidate dall’oggettività (Maturana, 1997), ma dalla loro adeguatezza a costruire domini di interazione in cui sia possibile esperire modificazioni reciproche di quelli che definiamo appunto “autocoscienza” e “realtà”: da questo punto di vista, si ritorna dunque all’assunto secondo il quale una spiegazione o una teoria scientifica (dunque, qualsiasi teoria psicoterapica) sono di fatto “una libera creazione della mente umana” come recitava Einstein, ma – rispondendo ad una domanda che lo stesso Einstein si faceva (Maturana, 1993) – rendono intelligibile l’Universo non perché spiegano un mondo indipendente dall’osservatore, ma perché spiegano la prassi di questo, utilizzando “le stesse coerenze operative che la costituiscono nell’agire linguistico. E’ qui che la scienza diviene poesia.” (Maturana, 1993, pag. 115)
Come ripetutamente esplicitato, dunque, uno degli aspetti fondamentali di questa prassi definita VMT, è dunque nella sua dimensione di “narrazione” di una storia, che viene scritta secondo le categorie della psicologia e che può dunque trasformare le regole che la animano: da questo punto di vista non è inopportuno far notare come il set/setting della VMT si colloca appunto nella logica di esplicitare tale dimensione narrativa, di cui fa parte la psicoterapia stessa in quanto tale: “Quel che rende una psicoterapia capace di guarire è una percezione immaginale di se stessa, quell’orecchio rivolto a ciò che sta facendo, dicendo, scrivendo. Essa cura costantemente il proprio linguaggio con un terzo occhio, un terzo orecchio. Ogni arte in cui si inaridisca l’immaginazione diventa una scuola letterale, una serie di tecniche, una professione” (Hillman, 1984, pag. VI della pref. italiana).
A questa prospettiva della psicoterapia come cura perché narrazione di sé stessa, Hilmman aggiunge una psicoterapia che è anche narrazione: “Credo che chi fa terapia con l’arte possa, meglio di chiunque altro, comprendere quanto spontaneamente l’intuizione si sviluppi dal lavoro immaginale. Quando la psicologia vorrà riflettere direttamente l’intuizione del regno immaginale – questa trascurata terza parte della psiche, o inconscio, come è stata poi chiamata – dovrà cominciare con il produrre immagini e metafore, dovrà battere le mani, cantare, danzare, raccontare storie e redigere un altro genere di storie cliniche, le quali, dopotutto, altro non sono che straordinarie fantasie. Le storie cliniche sono una forma narrativa che si è sviluppata negli ultimi quaranta anni e se ne sono ammassate a tonnellate negli ospedali di tutto il mondo. Queste storie, o resoconti, di operatori sociali parlano di problemi nel linguaggio della fantasia senza rendersi conto che sono narrativa. Perché non ci avvediamo che un caso clinico è una storia, che parliamo della vita nel linguaggio di questa particolare forma narrativa, che creiamo quel che Jung ha chiamato una “storia che cura”, un contesto immaginale per la vita che stiamo descrivendo, per cui quella vita può immaginare sé stessa in un altro modo ? Perché dovrebbe essere l’unico, il “paziente” , a dipingere per sé una nuova esistenza ? Non potrebbe il terapeuta, scriverne in modo immaginativa, in un’altra storia ?” (Hillman, 1985, pag. 13).
Il punto è che questa dimensione narrativa della psicoterapia non ricorre solo nel pensiero di quello che, bene o male, può apparire come un analista legato ad una concezione abbastanza classica della psicoterapia, quale Hillman può appunto sembrare.
Il pensiero jungiano e la la messa in crisi del concetto di scientificità della psicoterapia
Di fatto, la Terapia Narrativa è una classica terapia di impostazione costruttivistica, e nasce da correnti culturali che con i presupposti della psicologia analitica più o meno classica (anche se Hillman è chiaramente eccentrico anche alla collocazione jungiana) non sembrano aver nulla a che fare.
Come noto, la “realtà” per il costruttivismo è una costruzione che noi facciamo in qualitˆ di osservatori: “tutto ciò che è detto è detto da un osservatore … ad un altro osservatore che potrebbe essere lui stesso” dicono Maturana e Varela (Maturana e Varela, 1985, pag. 53). Se noi confrontiamo tale assunto con quanto qui di seguito dice Hillman, non possiamo che cominciare a porci alcune domande.
“Nonostante l’imbarazzo, è dunque meglio mettere in evidenza la soggetttività della psicologia, anziché ricoprirla con quella fantasia di oggettività che tanto infetta il nostro campo. Quindi non faremo finta che l’analista sia oggettivo, (Freud dietro il lettino, Jung e le sue conoscenze amplificate), e neppure ci intratterremo sulle nozioni di una psiche oggettiva, sul livello oggettivo dei sogni, e sul significato degli eventi psichici, che possono essere analizzati imparzialmente dallo psicologo impegnato in ricerche scientifiche o culturali sul materiale oggettivo: casi, sindromi, associazioni. Niente di questo materiale esiste indipendentemente dalle persone e dalla psiche dell’osservatore [sottolineatura dell’A. – N.d.R.] Questo cosiddetto materiale oggettivo è la materia più soggettiva della vita: riguarda ciò che le persone ricordano, come fantasticano, il luogo in cui amano” (Hillman, 1985, pag. 174).
Il fatto che non sembra potersi cogliere alcuna differenza tra le asserzioni di Maturana sulla realtà, la scienza, il ruolo dell’osservatore, e le idee di Hillman sulla psicologia (come scienza, appunto), dimostra di fatto che l’idea e la consapevolezza di una psicoterapia che sia narrazione attraverso la soggettività dello psicoterapeuta, è un’idea che nacque molto prima di quanto ora viene descritto dai terapisti di impostazione costruttivistica. Come poi si vedrà, lo stesso si potrà dire con notevole evidenza di uno degli strumenti principe delle terapie strategiche, cioè l’uso del paradosso in psicoterapia.
Il punto è che tutta la corrente jungiana, di cui appunto Hillman è comunque un continuatore, porta con se stessa sia la messa in crisi della psicologia come scienza dell’oggettività, sia la premessa che la psicoterapia è in gran parte narrazione, e cura attraverso la narrazione. A prescindere infatti da quel che Popper dirà solo nel 1963 (Popper, 1963) circa la scientificità degli assioni psicanalitici già nel 1946 – dunque anticipando qualunque altro epistemologo – lo “psicologo-analista” Jung affermava che “La psicologia deve abolirsi come scienza, e proprio abolendosi come scienza raggiunge il suo fine scientifico” (Jung C.G., 1976). Sostanzialmente, possiamo anzi dire che tutto il senso jungiano del “fare psicologia” è il senso di un narrare sé stessi, i propri miti, il proprio mondo immaginale.
Non è un caso, difatti, che Jung arrivò alla psichiatria, e dunque alla psicoterapia, solo e soltanto perché attratto da questa dimensione di racconto personale che ogni descrizioni “psichiatrica” porta inevitabilmente con sé.
Fino al momento di laurearsi , infatti, egli voleva intraprendere la carriera di chirurgo. Ma ebbe una vera e propria “illuminazione” allorché prese fra le mani il testo di psichiatria di Kraft-Ebing (del 1890) e vi lesse: “ogni teoria” psichiatrica è anche una confessione del proprio autore” (Jung, 1962, pag. 146). Come Jung stesso esplicitamente dichiara, fu questa frase a rendergli affascinante la psichiatria, e sulla concezione che ne deriva, fondò – come più volte ripete nei suoi scritti – la propria adesione ad essa e tutta la propria teoria.
Di fatto, tale soggettivizzazione della psichiatria non è presente – nel lavoro di Jung – solo per ciò che concerne le teorie, ma anche per la peculiarissima prospettiva attraverso cui veniva creato il setting jungiano e per l’inscindibile legame che il setting creava tra la teoria e la prassi jungiana.
Il setting jungiano come il set delle regole emergenti dalla relazione
Non è dunque un caso che il setting di Jung sia stato quanto mai vario e variabile, che venisse costruito intorno alla relazione che emergeva dall’incontro fra il “paziente” e l’ “analista””, e che ammettesse una notevole elasticità nelle regole, proprio dimostrando che l’analista aveva nella relazione e non nel setting fine a sé stesso il punto di riferimento per la costruzione del luogo e del sistema di terapia. Ciò è di fatto dimostrato – ad esempio – da come Jung privilegiasse, o almeno favorisse, i rapporti “extrasetting” tra pazienti e terapista, come ben ricorda la più accreditata biografa jungiana, B. Hannah.
Già nel 1912 infatti “la terapia jungiana andava ben al di là delle pareti del gabinetto di consultazione, ed Jung ben presto [1912 circa, appunto, N.d.R] rinunciò alla regola freudiana che vuole che l’analista non incontri mai i pazienti se non in sede di analisi. Non era d’accordo con gli analisti freudiani i quali evitavano ogni rapporto sociale con i loro pazienti al di fuori della situazione analitica, e cominciava a sentir la necessità di conoscere i propri pazienti e le reazioni di questi in un contesto assai più simile alla vita esterna di quanto non lo fosse la stanza delle sedute. Ma era proprio fuori di questa che gli capitava assai spesso di saperne di più sul conto degli analizzandi, senza contare che questi a loro volta imparavano a conoscere sè stessi soprattutto nella vita di ogni giorno. Ad evitare malintesi, va tuttavia sottolineato che Jung si è sempre dichiarato decisamente contrario ad ogni forma di analisi di gruppo” (Hannah, 1978, pag. 181). Il Circolo Psicologico di Zurigo nacque (op. cit., pag. 182) per tali motivi: oltre a seminari e incontri culturali, vi si organizzavano feste, danze, veglioni, nei quali Jung si produceva persino come animatore: “seminari e contatti sociali del genere continuarono anche dopo la seconda guerra mondiale rivelandosi quasi altrettanto utili, per lo sviluppo dei pazienti di Jung, dell’analisi stessa” (Hannah, 1978).
L’aspetto dunque quasi conviviale dei rapporti fra analista e pazienti, del resto, fu riaffermato in Italia dal primo analista jungiano che vi abbia esercitato, il dr. E. Bernhard, allievo di Jung: “ad Anna Quagliata [ analista jungiana tra le prime allieve di Bernhard, N.d.R. ] proprio il giorno prima di morire, Bernhard aveva confermato questo concetto, e cioè che ‘bisogna riunirsi e mangiare e bere insieme e dialogare fra noi, come fra amici’” (Carotenuto, 1978). Il setting jungiano è pertanto un setting allargato e allargabile: definirlo “ortodosso” solo se si attiene alle rigididità delle regole freudiane, è dunque un grave errore teorico, culturale, epistemologico, e questo appunto perché il setting jungiano è sempre stato costituito sulle regole della singola relazione. Da questo punto di vista, utilizzo il concetto di setting come “set” di regole per esprimere come questo “insieme” (un set, appunto) di regole sia anche il luogo della messa in scena (il set, nel senso cinematografico) della messa in scena di questa relazione.
Senza che ciò nulla esprima sulla validità di un setting freudiano applicato a un’analisi jungiana, occorre infatti considerare che una tale modulabilità delle regole era, da parte di Jung, e di quegli jungiani che lo hanno seguito su tale strada, quanto mai coerente a quella visione “mercuriale” e – nella mia opinione – “costruttivista” che egli aveva della psiche e della psicoterapia. Di fondo, il setting jungiano appare molto più elastico e costruito ad hoc sulla relazione di quanto non lo sia quello freudiano (Trombetta, 1989).
D’altra parte, se si considerano le chiavi interpretative che Jung utilizzava nel suo setting e nell’interpretazione dei sogni (e delle quali ben ci parla la Hannah), ci si rende conto che le regole del suo fare “psicoterapia” possono essere spiegate solo come regole che emergevano sempre dalla relazione in quanto tale: nel suo “interpretare” il qui ed ora del “paziente” , non vi era distinzione fra quel che era del “paziente” (le sue associazioni) da quel che era dello psicoterapeuta (il suo riferirsi a miti, archetipi, leggende). In questo senso, era chiaro al “paziente” che quanto accadeva in analisi era frutto di una comune costruzione di quella analisi e quel momento.
Anche se dunque per tutta la carriera Jung continuò a ipotizzare una realtà oggettivabile e a considerare lo psichismo sotto la metafora dell’ “energia”, egli giunse lo stesso a considerazioni sicuramente atipiche per quanto riguarda l’oggettività della scienza, certo molto vicine al costruttivismo. A mio avviso, tale corrente non ha mai saldato con lui un debito certo molto maggiore di quello che gli riconosce.
Nel continuo pensare di Jung alla “materia” e alla “psiche” come a due modi di osservare la stessa realtà; nei suoi studi con il fisico Pauli e nei suoi interessi nella fisica quantistica; nella dichiarata ammissione di empirismo e soggettività su cui impernia la propria ricerca psicologica (che appunto definisce come sua); nello stesso concetto di “sincronicità” e nel suo modo di concepire appunto il “setting”, ci sono sicuramente più che i germi di un riconoscere al processo conoscitivo – in specie a quello della psichiatria – una natura strettamente autoreferenziale.
Negli anni a partire dal 1980 – come già ripetuto – Maturana arriverà a dire (insieme ad altri esponenti del costruttivismo) che la coscienza non appartiene alla corporeità che la esprime (Maturana, 1993), e che quello che definiamo come spazio psichico e mentale appartiene in realtà al dominio di interazione dei sistemi viventi, cioè che non esiste come tale (Maturana, 1997) ma che emerge come qualità di quella trofallassi comunicativa nella quale come sistemi viventi siamo immersi (Maturana e Varela, 1992).
Se noi rileggiamo dunque da un altro punto di vista il concetto di “Inconscio Collettivo”, e gli assegniamo non una concretezza topica ed energetica, ma una sua esplicatività funzionale, possiamo cominciare ad ipotizzare che Jung avesse fin da allora intravisto i semi della modernissima concezione sistemica della coscienza umana, che emerge come tale solo nella fittissima trama costituita dalla deriva di tutti gli accoppiamenti linguistici e sociali che intessono gli esseri umani.
Consequenzialmente, si può con gran evidenza pensare che il dissidio tra Jung e Freud solo erroneamente possa essere inteso come esploso a causa del ruolo da attribuire alla sessualità nell’etiologia dei disturbi psicopatologici. Di fondo, Freud rivendicava alla nascente scienza “psicologica” e alla “analisi della psiche” i rigori dell’oggettività che sembravano illuminare sempre più la scienza di fine secolo – il secolo appunto dei lumi della scienza; Jung si distaccò da tale prospettiva non tanto per affermare l’oggettività di ciò che aveva “scoperto” (la Teoria dell’Inconscio Collettivo, gli Archetipi, e via dicendo), ma, come appunto dice chiaramente, per rivendicare che il metodo e la dimensione di questa ricerca, riconoscessero l’ “equazione personale” dello sperimentatore come inscindibile dall’oggetto della conoscenza.
C’è chi l’ha definito “nazista”, chi l’ha inquadrato come “l’ultimo grande discepolo degli gnostici medievali” di cui “la parte maggior e più nota delle teorie jungiane non solo non ha a che fare con il metodo scientifico, ma neppure con le leggi che regolano i comportamenti” (Jervis, in Jung, 1979, pag. XX della prefazione): di fatto, solo oggi ci si comincia a render conto che è l’inesistenza di queste leggi – per lo meno se considerate come tali – a dar ragione del modo Jung di fare psichiatria.
A mio avviso, tutto ciò è dovuto al fatto che di questo psicoanalista, apostata non solo in psicoanalisi, non si è voluto cogliere un aspetto fondamentale: quello di essere stato uno dei primi grandi epistemologi che, proprio nei primi decenni di questo secolo, e dunque in netto – quindi per chi non lo capiva e ancora non lo capisce, “delirante”, anticipo sull’era dell’informazione – apertasi nella seconda metà di questo secolo – aveva cominciato a percorrere un modo di fare scienza in cui i nessi “causali” – descritti oggettivamente e comprovati dall’oggettività – andassero riscritti alla luce dell’equazione personale dello sperimentatore che li intravedeva come tali.
In altri termini, se si pensa a Jung come al primo grande epistemologo del nostro secolo, specie nella sua capacità di porre l’oggettività entro la parentesi dell’equazione personale dello sperimentatore, in specie dello psichiatra, è immediato dimostrare come egli sia stato il primo (fra tutti i suoi studi, citiamo ancora quelli sulla fisica) a intravedere che le spiegazioni scientifiche e il processo di conoscenza in genere poteva essere spiegato solo come autoreferenziale alle premesse di chi lo costruisce come tale.
Si può dunque affermare che molto dell’oblio e – per certi versi – della ghettizzazione di cui è stato oggetto Jung nella cultura occidentale, siano dovuti al fatto che fu un precursore troppo avanzato della moderna epistemologia.
A mio parere, vi è comunque un dato storicamente certo in tutta la vicenda che chiamiamo psicoterapia, ed è un dato sicuramente paradossale: sin dai primordi stessi di questa scienza, il vero scontro non è stato tra coloro che sostenevano o mettevano in crisi l’importanza della sessualità nell’etiologia delle nevrosi umane, Freud e Jung, appunto, ma tra il primo come propugnatore di una visione della psicologia in cui questa rientrasse nell’oggettività rigorosa e galileiana, e il secondo come il geniale anticipatore di una epistemologia che affermava il ruolo dello sperimentatore nella creazione dei nessi descritti come causali.
Da questo punto di vista, attraverso Freud e Jung si scontrarono dunque non due differenti ipotesi sull’etiologia della malattia mentale e sul concetto di libido, ma due diverse epoche: il grande razionalismo di fine ‘800, che sperava di spiegare il mondo con la ragione, la scienza, l’energia; e un tempo ancora da venire, che dava all’osservatore e al concetto di informazione un ruolo centrale nella definizione della conoscenza della conoscenza.
Ciò che resta incredibile di Jung, letto in questo senso e da questo versante, è il suo aver anticipato – quasi in silenzio – l’epistemologia di fine millennio.
LE TEORIE IN PSICOTERAPIA: IL CONCETTO DI FALSO E QUELLO DI SPERIMENTAZIONE
Esperienze pragmatiche: una “finta” psicoterapia per veri “psicoterapeuti”
Per meglio esplicare il punto di vista su ciò che è la psicoterapia e che si andrà delineando in questo scritto, ritorno a descrivere alcune delle esperienze occorse nel set/setting della VMT.
Come chiarito precedentemente, uno dei punti fondamentali nella costruzione delle storie, è la messa in crisi del concetto di “psicoterapia” come sistema scientifico convalidato dall’obiettività, e dunque in grado di descrivere obbiettivamente le differenze fra “illusione” e “percezione”.
Al proposito, ogni set/setting di VMT prevede come punto praticamente obbligato di ogni narrazione, la creazione di una “nuova” psicoterapia da parte dello “psicoterapeuta”, il quale inventa di volta in volta, delle sue personalissime psicoterapie, ovviamente proclamando sempre che l’inflazionato mondo della psicoterapia ha bisogno di quella chiarezza che la sua invenzione apporterà. Oltre a fondare continuamente le relative associazioni, organizza anche “Trainings di Formazione Quadriennale in Psicoterapia”, di cui garantisce immancabilmente il riconoscimento da parte delle apposite commissioni ministeriali, e a cui fa accedere – per ovvii motivi – chiunque ne faccia richiesta, anche se sprovvisto dei requisiti più elementari.
Al riguardo é interessante ricordare un episodio abbastanza importante, legato all’utilizzo nel video di una di queste “finte” psicoterapie.
Del gruppo dell’epoca facevano parte – come “pazienti” una psicologa ed un sociologo, la cui collaborazione non solo fu preziosa, ma dimostrò anche come le differenze nei ruoli sono essenzialmente legati alle prospettive con cui vengono descritti.
L’episodio in questione, che successivamente venne denominato il “Rosenhan al contrario” avvenne all’epoca in cui ancora non era stata varata l’attuale (e criticata) Legge Ossicini sulla regolamentazione delle Scuole di Formazione in Psicoterapia.
In un articolo scritto da Rosenhan nel 1973 e ormai divenuto famoso, si racconta di come alcuni individui “normalissimi” vennero ricoverati in ospedale psichiatrico come “schizofrenici”, perché avevano volutamente mentito circa le proprie condizioni psicopatologiche, affermando di “sentire delle voci”.
Vennero riconosciuti tutti affetti da episodi psicotici e trattenuti in ospedale psichiatrico anche quando mostrarono un comportamento normalissimo; uno fra i fatti più sconcertanti fu che solo i pazienti “veri” si accorsero che gli pseudopazienti non erano “matti” davvero, mentre gli “psichiatri” si mostrarono sordi a qualunque asserzione di sanità) (Rosenhan, 1981).
Per quanto riguarda il nostro set/setting, avvenne qualcosa di opposto e complementare.
Come altre volte, nella storia era stata inserita una “finta” psicoterapia, la Terapia Multidimensionale. Si era nel febbraio 1989, e in attesa della Legge Ossicini nel nostro paese si contavano ben cinquecentocinquanta Centri e Associazioni private (Filippeschi e Celano, 1988) che professavano una qualche psicoterapia e offrivano, sotto forma dei fatidici “Corsi di Formazione Quadriennale”, didattica, sempre sperando il fatidico riconoscimento legale.
Presi spunto da tale situazione – e dal fatto che la psicologa in questione era alla ricerca di un “Corso di Formazione” affidabile, e con tutto il gruppo creammo la ” Terapia Multidimensionale”.
Di tale terapia venne preparato – per esigenze sceniche – il relativo materiale illustrativo (alcuni opuscoli destinati a pubblicizzare nel video la “Terapia Multidimensionale” ed il suo “inventore”). Tale preparazione faceva parte del set/setting stesso della VMT , e non era privo di spunti interessanti: non solo occorreva buttare giù qualche nucleo concettuale su cui strutturare un modello operativo (il che era anche difficile, perché spesso si rischiava di creare dei duplicati di psicoterapie regolarmente “esistenti”, e citate in qualcuno dei manuali o dei testi appositi), ma bisognava anche inventare il relativo “setting” e studiare il modo in cui lo “psicoterapeuta” della storia l’avrebbe venduta ai suoi “pazienti”.
Quanto accaduto successivamente è sicuramente il diretto riflesso di una confusione che emergeva in quegli anni grazie alla particolare situazione legislativa in atto, ma non può non essere attribuibile alle logiche interne a ciò che definiamo “psicoterapia”.
Per quanto riguarda il video in questione, il soggetto prevedeva che lo “psicoterapeuta” avesse voluto inventare una psicoterapia che riunisse in sé quelli che sembravano i “trend” psicoterapici più in voga in quegli anni. Per tale motivo, la “Psicoterapia Multidimensionale”, si fondava sull’idea che il disagio mentale derivi dalla mancata armonizzazione delle tre dimensioni in cui l’Essere Umano sarebbe (secondo la “falsa” psicoterapia in questione), “tripartito”: quella psicologica, quella corporea e quella spirituale.
La Terapia Multidimensionale si proponeva di riportare la perduta armonia operando attraverso un intreccio di pratiche varie, ognuna inerente a ciascuna delle tre dimensioni: colloqui di analisi psicologica per lo studio “del profondo”; tecniche gruppali di espressione e “comunicazione” corporea; esperienze di meditazione per la conoscenza ed il risveglio delle energie interiori sotto forma di “maratone” collettive in cui sarebbe stata esperita la Coscienza del Gruppo come entità energeticamente autonoma (e con possibilità di dialogare con essa attraverso momenti di profonda concentrazione interiore). Ovviamente, lo “psicoterapeuta” del film sperava in tal modo di triplicare i guadagni che gli sarebbero venuti da ciascun singolo paziente.
Ciò che mi interessa raccontare, accadde fuori dal set/setting della VMT e – pur se riferito alle dimensioni dell’esperienza – dimostra come anche in “psicoterapia” la “conoscenza” sia un comportamento definito adeguato ad un contesto definito tale da una domanda (Maturana e Varela, 1985)
Accadde dunque che una parte delle riprese si svolgessero, per esigenze di copione, in uno studio psicoterapico diverso da quello del terapeuta del gruppo e che gli opuscoli utilizzati per le riprese venissero dimenticati nella sala d’attesa dello studio. Due giorni dopo, preceduta da un annuncio su un quotidiano, si svolse in quello studio una conferenza su temi inerenti alla psicologia (separazioni coniugali). La segretaria di questo studio non rimosse però i volantini, pensando che si trattasse di vero materiale di propaganda. Nei due – tre mesi successivi (ma l’ultima chiamata avvenne circa sei mesi dopo la conferenza) giunsero al mio studio una ventina di telefonate circa di persone che chiamavano per informarsi sulle modalità di cura della “Terapia Multidimensionale”, e sugli eventuali modi per accedere ad essa. In altri termini, di quelli che avevano telefonato nessuno aveva dubitato che potesse esistere “per davvero” una Terapia Multidimensionale. Il loro dilemma, semmai, era quanto fosse “costosa”. Non fu facile dare una risposta a tali richieste e non fu facile uscire da tale impasse.
Dopo le due prime telefonate cui reagii con una gran sorpresa e non poco imbarazzo, e che liquidai dicendo che “la Terapia Multidimensionale era una specie di scherzo” (lasciando apparentemente turbati gli interlocutori), decisi di approfondire il fatto. Insieme alla psicologa che faceva parte del gruppo di VMT (e dunque in una posizione molto atipica rispetto ad una “paziente” ortodossa) studiammo qualche domanda chiave da proporre agli eventuali nuovi interlocutori (che appunto non mancarono) per capire quale idea avessero i chiamanti della “psicoterapia Multidimensionale”.
Appurammo che il credito dato a tale psicoterapia era dovuto principalmente al fatto che essa esisteva.
Di fatto, però, l’unica prova della sua “reale” esistenza era solo il relativo opuscolo: quattro facciate, di scarsa accuratezza grafica (dato il computer utilizzato, un ormai inesistente MSX) che oltre ad una immagine del suo “inventore” in posa ispirata (prima pagina, ovviamente), contenevano brevi cenni su “teorie” e “metodi” della Terapia Multidimensionale.
Nessuno degli interlocutori che chiesero informazioni mise mai in dubbio l’esistenza della Terapia Multidimensionale, o di qualcuna delle sue pratiche, quali i colloqui psicologici, gli incontri di gruppo, e le maratone di Meditazione: tantomeno, nessuno di loro mise mai in dubbio che in nome di teorie e concetti quali quelli propugnati dalla VMT, si potessero curare davvero problemi e disturbi psicologici.
Qualche perplessità venne avanzata circa la serietà del terapeuta che si propagandava in quel modo, ma la misura della sua “buona fede” veniva cercata nella assenza di esosità e nella serietà con cui applicare la dottrina e le prassi propagandate.
In altri termini, quel che interessava a chi telefonava non era tanto l’oggettivitˆ della adeguatezza di una “terapia”, ma nella ortodossia con cui si praticava una sorta di “credo” la cui efficacia era data per scontata a priori. Fra l’altro, tale atteggiamento strettamente prodomico ai dissidi fra i seguaci delle varie teorie psicoterapiche: il contenzioso non riguarda mai le premesse della teoria, ma la fedeltà della applicazione. Il che rende appunto conto di quanto possa essere definita “oggettiva” qualsiasi prospettiva teorica in psicoterapia.
A conti fatti, uno degli aspetti più preoccupante della vicenda fu che la voluta reboanza e prosopopea dell’opuscolo pubblicitario della Terapia Multidimensionale – il cui linguaggio si allineava ai modi caricaturali del video – non indusse nessuno della ventina di persone che chiamarono (fra cui due futuri psicoterapeuti in cerca di un “Training Quadriennale”) a dubitare della bontà e serietà della proposta. In altri termini, quanti telefonarono si mostrarono interessati ad approfondire i canoni culturali ed operativi della Terapia Multidimensionale, e non colsero minimamente la voluta ed “evidente” (almeno per coloro che avevano preparato il testo) volontà truffaldina del messaggio.
Le brevi interviste rivolte a chi telefonava permisero di approfondire quali fossero i possibili “marker” che rendevano credibile non solo la “reale” esistenza della “Terapia Multidimensionale”, ma – anche – la sua “verosimile” efficacia e credibilità terapeutica.
Da questo punto di vista, sembra che il “segnale” più efficace fosse stato nel fatto che la Terapia Multidimensionale consisteva appunto in una “integrazione” di filoni della psicoterapia “realmente” esistenti (il che dava – paradossalmente ? – ragione proprio allo “psicoterapeuta” della storia…), la non indifferente farcitura di citazioni reali di autori “reali”, un voluto rimarcare – nei volantini – l’appartenenza della Terapia Multidimensionale al “filone” alternativo della “psicoterapia” e il conseguente esplicito tono oppositivo all’establishment “psicoterapico” posto nel volantino.
Un altro aspetto abbastanza emblematico della vicenda furono le cautele (o meglio: il senso che avevano queste cautele) con cui si dovette rispondere a chi chiedeva notizie di questa nuova psicoterapia. Dopo le prime due telefonate, fu infatti facile intuire che non era molto semplice dare – per telefono – una risposta.
Nei colloqui svoltisi dunque nello studio, la spiegazione che risultò più adeguata a non turbare eccessivamente l’interlocutore fu sostenere solo una parte della verità, e cioè che la Psicoterapia Multidimensionale “non esisteva” e che il materiale “serviva ad un film”.
Ciò provocava comunque una forma di sconcerto nel potenziale paziente della nuova psicoterapia, a volte un po’ di irritazione per l’inutile colloquio svolto, spesso una qualche delusione sul proprio essersi “ingannato” o – in un ridotto numero di persone – il sospetto che “sotto ci fosse qualcosa”.
In due o tre casi, ci furono reazioni di sospetto: era palpabile che alcuni degli interlocutori non credevano alla non esistenza della Psicoterapia Multidimensionale, e sospettassero che li volevamo escludere dalla relativa pratica per motivi a loro ignoti, forse perché – secondo loro – non li ritenevamo all’altezza. Furono questi due o tre casi nei quali non fu facile dare spiegazioni francamente conclusive.
Sul momento, ci spiegammo tale reazione con la capacità dei nostri interlocutori di captare quel livello di inganno e di trama occulta che effettivamente esisteva nel nostro atteggiamento, e nel non saperselo spiegare altrimenti. In altri termini, la loro reazione, anche se definibile “paranoidea”, dava atto di qualcosa che esisteva “davvero”.
D’altra parte, era difficile spiegare la vicenda per come si era realmente svolta, sostenendo cioè che la “Psicoterapia Multidimensionale” era una finta psicoterapia, inventata nell’ambito di una “vera” psicoterapia di gruppo basata sulla creazione di videofilm, nei quali si narravano le vicende di uno “psicoterapeuta imbroglione” che “inventava finte psicoterapie” appariva una spiegazione troppo conturbante per poter essere data tout court all’interlocutore.
Nella ventina di colloqui svoltisi (in sei mesi) allo studio, appurammo comunque che il vero problema non risiedeva nel definire “vera” o “falsa” “quella” terapia.
Per chi telefonava, quella terapia esisteva davvero a prescindere dai volantini e dal nome che aveva: in altri termini, per tutti coloro che erano venuti ai colloqui, era ovvio che, basandosi su “quelle idee”, (l’essere umano soffre perché non integra bene le sue tre dimensioni) si potessero “curare” i disturbi psicopatologici.
Per chi telefonava (fra di loro vi furono anche due futuri psicoterapeuti in cerca di “Training di Formazione”), il vero criterio discriminante era un altro: era nel ricevere la garanzia, che quanto era scritto nell’opuscolo era condiviso dallo psicoterapeuta, che tale pratica era dunque condotta in buona fede e con coerente aderenza alle tesi professate, e non per scopo di lucro (fatto salvo un ragionevole guadagno).
Da questo punto di vista, la psicoterapia diventa tranquillamente una questione di marketing: ogni partecipante era arrivato ai colloqui perché già dava credito alle idee lette nel volantino. Ciò comporta che chiunque voglia creare una “psicoterapia” in grado di essere percepita come efficace, deve solo studiare a tavolino quale sono gli orientamenti in materia della parte di utenza che vuole raggiungere – o identificare una “fetta di mercato” attraverso ciò che questa ritiene idoneo come “psicoterapia”, e presentarglielo come costruzione teorica posta a priori della loro richiesta.
Lo sviluppo di tali prospettive ci permise di fare, con la Psicoterapia Multidimensionale, qualcosa di più di quel che ho sino ad ora descritto: il nostro piccolo “Rosenhan al contrario” arrivò infatti a prevedere un piccolo inganno ma – purtroppo o per fortuna ? – lo svolgemmo solo a metà (parte di esso è narrato in un mio articolo uscito nel 1990) (Giordano, 1990).
Invitammo infatti due dei potenziali utenti della Psicoterapia Multidimensionale – i futuri psicoterapeuti – che desideravano un Training di Formazione – ad un incontro di gruppo della VMT, ma dicendo che si trattava di un incontro di gruppo a mediazione corporea della Terapia Multidimensionale. Anticipammo la presenza della videocamera, ma la giustificammo con la necessità di preparare un videotape illustrativo dell’esperienza.
Agli altri partecipanti al gruppo di VMT (solo la psicologa era informata dei veri motivi di questa presenza) spiegammo che i due partecipanti avrebbero seguito solo qualche “seduta” ed erano lì in qualità di potenziali futuri “collaboratori”, desiderosi di capire qualcosa di più dei gruppi di VMT, e decidere eventualmente se parteciparvi.
Dicemmo ancora, al gruppo, che questi due psicoterapeuti dovevano farsi una idea molto personale della VMT: occorreva dunque che il gruppo, per una volta, tentasse di girare la scena con il minimo di incidenti e problemi tecnici. La settimana prima dell’arrivo dei due colleghi, preparammo bene la scena da girare e, così, feci in modo che le distinzioni fra il set ed il setting si riducessero al minimo.
Nell’incontro cui assistettero i due psicoterapeuti il gruppo recitò sé stesso mentre frequentava un incontro di gruppo a mediazione corporea della Terapia Multidimensionale: qualunque intoppo si verificasse nella “scena” da girare come tale, veniva risolto molto rapidamente, e feci in modo che quelli che nella scena erano gli interventi (ridotti al minimo) dello “psicoterapeuta”, nella “realtà” apparissero invece interventi del regista relativi al video illustrativo.
Si svolse un solo incontro di questi: i due partecipanti ritennero infatti che l’uso della videoregistrazione non era compatibile con la necessaria spontaneità dell’esperienza che pensavano di fare, e dissero che sarebbero tornati.
Uno solo di loro richiamò dopo un mese, ma gli fu detto che i gruppi di Terapia Multidimensionale erano stati chiusi.
Recentemente, ho avuto notizia che nel WEB, è da poco presente un sito testualmente così presentato nei Motori di Ricerca: “Spirit, Mind and Body: The Trilogy of Man (Websites to help you help yourself and to better) http://membrane.com/beyond/index.html.
Occorre infatti cominciare a chiedersi qual è il confine della psicoterapia, e se ne esistono di “false”: e in base a cosa sono allora definibili come tali, e quali conseguenze abbia – a livello di metodologia scientifica – la risposta.
E, soprattutto, quanto tutto ciò sia stato oggetto, da parte degli psicoterapeuti, di riflessioni sulla natura della psicoterapia.
Le “false” psicoterapia e la sperimentazione vs placebo
Di una sostanza – e di una sostanza definita “farmacologica” – si può dire se è veramente quella definita come tale: ad esempio, si può appurare se in una capsula che dovrebbe contenere una benzodiazepina vi è veramente quella benzodiazepina.
Operando poi con opportune metodiche, è poi possibile sperimentare se l’azione di un farmaco è veramente quella che ci si aspetta che sia, ovvero qual è “realmente” l’efficacia di una data sostanza chimica riguardo ad una data malattia o sindrome.
Il punto è che ogni sperimentazione in tal senso, si fonda sul fatto che la sostanza in questione è testata nei confronti di una sostanza “placebo”, cioè chimicamente inerte.
Ciò avviene nelle cosiddette sperimentazioni a “doppio cieco”, nelle quali il medico che somministra la sostanza non sa se la sostanza che somministra è veramente quella testata, oppure del talco inerte.
Le domande da porsi, relativamente alla psicoterapia, sono dunque diverse. E vertono principalmente sul concetto di “falso”: possono esistono delle false “psicoterapie” ? E qual è il criterio attraverso cui le definiamo tali ? In altri termini: qual è il confine entro il quale una psicoterapia è tale e oltre il quale non è più tale ?
Ciò comporta di fatto alcune riflessioni sulla possibilità di affermare l’efficacia di una psicoterapia e, soprattutto, l’efficacia di una psicoterapia rispetto ad un altra.
La prima di queste riflessioni nasce dal capovolgere l’obiezione che comunemente si fa proprio circa l’efficacia delle psicoterapie: si sostiene infatti che molti dei successi ottenuti in psicoterapia sono dovuti al cosiddetto “effetto placebo” (Nardone, 1994).
Il problema nasce però rovesciando completamente il punto di partenza della domanda: sicuramente in psicoterapia può esistere quello che usualmente definiamo “effetto placebo”. Ma esiste qualcosa che è definibile come una psicoterapia “placebo” ?
In altri termini: esiste, e – se non esiste, cosa dobbiamo dedurne – una sperimentazione in cui ad un gruppo di pazienti è somministrata – all’insaputa dello psicoterapeuta che la somministra – una psicoterapia “vera” e ad un altro gruppo – e sempre all’insaputa dello sperimentatore – una psicoterapia “falsa”, che stia alle altre come il talco sta alla benzodiazepina, vale a dire che sia una psicoterapia “psicologicamente inerte” ?
E’ evidente che tale possibilità non c’è: la psicoterapia non è una sostanza.
Pertanto, occorre chiedersi se le varie statistiche relative all’efficacia delle diverse psicoterapie sono convalidabili entro la comune prassi scientificia: e non per la validità delle metodice e dei sistemi utilizzati, quanto per la natura della psicoterapia in sé, che sfugge a una sperimentabilità galileiana (mancando appunto la possibilità, ad esempio, di convalidare le varie psicoterapie in un esperimento a “doppio cieco”).
Di fatto, le statistiche in psicoterapia sono fondate o su un confronto fra le varie psicoterapie relativamente ad una data patologia, o su un confronto fra una specifica psicoterapia e un trattamento farmacologico, o su un confronto fra un gruppo di malati non trattati e un gruppo di malati trattati con una certa psicoterapia (Nardone, 1994).
E’ possibile infatti – almeno in teoria – condurre una sperimentazione in cui un osservatore analizzi risultati ottenuti da terzi con metodiche psicoterapiche di cui egli ignora la natura: ma non è possibile che ad un paziente venga somministrata un qualcosa di definibile come una “psicoterapia placebo” – cioè un qualcosa di confezionato come se fosse una psicoterapia “vera” ma che, non avendo alcun effetto sulla persona su cui la si pratica, è di fatto una “falsa” psicoterapia, che – come il talco della farmacologia clinica – permette il classico confronto del “doppio cieco”.
Al massimo, si può osservare cosa accade ad una persona se la si lascia appunto in “assenza” di terapia: ma è ancora tutto da dimostrare che questo significhi l’assenza di valenze “psicoterapeutiche” nelle relazioni con quanti si prenderanno cura di lui nel frattempo: e che dunque assenza di psicoterapia “ufficiale” implichi assenza di valenze psicoterapiche nei comportamenti di altri che si prendono cura del malato.
Il rilievo non è peregrino come ai sostenitori della validità delle statistiche in psicoterapia può sembrare: in farmacologia una classe di farmaci, studiata per una certa sindrome, può divenire oggetto di sperimentazione nei confrotni di altre patologie se dimostra incidentalmente di possedere effetti terapeutici in altri campi. E’ accaduto – tanto per restare in tema – con l’isoniazide, sperimentata dapprima come antidepressivo e che ha poi trovato posto nella farmacopea come antitubercolare. In psicoterapia è possibile strutturare una osservazione del genere – cioè isolare comportamenti che, ritenuti “psicoterapeuticamente indifferenti”, dimostrino a posteriori valenze di tale genere ?
Di fatto, non esiste tale possibilità – non riferibile perlomeno a classi di comportamenti standardizzabili come tali.
Tutto questo ci impone però di considerare la psicoterapia come qualcosa di non trattabile secondo le comuni sperimentazioni scientifiche, dato che:
1) in psicoterapia non sono possibili statistiche in cui l’efficacia di una psicoterapia sia comprovata da sperimentazioni a doppio cieco, perché non è possibile testare in psicoterapia vs un placebo;
2) non sono possibili molte delle osservazioni con cui di solito si procede nella sperimentazione farmacologico-clinica;
e ciò comporta, secondo me, un dato molto semplice.
Specie pensando che appare evidente come non sia possibile costruire o inventare una psicoterapia definibile – con criteri tutti da accertare – “falsa”, e come non esista qualcosa che assomigli ad una psicoterapia da far apparire tale ma che sia “psicologicamente inerte”. E’ qui infatti che nella mia prospettiva emerge una riflessione. Popper sostiene, come noto, che la psicoanalisi si basa su dati inconfutabili e inverificabili.
A mio avviso tale assunto andrebbe riscritto: in psicoanalisi (e in psicoterapia) ad essere utilizzato in modo infalsificabile e indimostrabile è proprio il concetto di “falso”.
LA PSICOTERAPIA COME SITUAZIONE TRANSCONTESTUALE
Alla ricerca del confine di un confine
Esistono nel mondo oltre cinquecento diversi tipi di Psicoterapia (Nardone, 1994).
Come afferma Szasz, (Szasz 1978) ogni attività umana è stata proposta sia come psicoterapia sia come patologia. Esistono così psicoterapie senza quasi una teoria che le supporti, altre ispirate alle più semplici o alle più deleterie attività umane: “Cooking as Therapy”, “Soap Opera Therapy”, “Sailing Therapy”, “Therapy with the Dog”, (Szasz 1978); altre ancora dai nomi esotici e quasi alieni: la Morita Therapy, o la Naikan Therapy giapponesi, propagandate in USA dal TO DO Institute (Middlebury, VT) o la “Psicoterapia axiotica” di Lhotsky, o la Chitamnie di Baruk (Bazzi, 1970).
E’ qui interessante notare come già nel 1964 W. Frankl affermava che in psicoterapia “è valido l’adagio: quot capita tot sistemata”, una parere, questo, che uno psicoterapeuta non psicoanalista come Bazzi (che già polemizzava sui tentativi egemonizzanti della psicoanalisi in psicoterapia) riportava – evidentemente spinto da un problema già vivo – più di trenta anni fa, in uno dei rari volumi dell’epoca in cui si parla delle psicoterapie come insieme di differenti trattamenti e non come una pratica da ricollegarsi alla sola psicanalisi (Bazzi, 1970).
Per citare poi un esempio riferibile ad una teoria molto ortodossa, possiamo fare il caso delle differenze escogitate per differenziare il setting psicoanalitico ortodosso da quello della psicoterapia psicoanalitica: il numero di sedute settimanali (non quattro, ma tre o due), forse anche l’utilizzo della sedia invece che del lettino, la frequenza nelle supervisioni (ogni quindici giorni e non ogni settimana), eccetera, tutte differenze che sembrano motivate più da esigenze di mercato e di marketing (Migone, 1995) che non da criteri metodologici utilizzati in senso “scientifico”.
Un esempio – o tutta una intera tematica – riferibile a tutt’altra corrente psicoterapica è quella relativa alle Terapie Sessuali a base di “partner sostitutive/i”: come vedremo, il loro relativo inserimento in una storia creata con la VMT ci ha permesso di considerare – sia pure a livello ironico, ma non per questo meno veridico – come ci sia qualcosa di sconcertante nella possibilità di non distinguere, a livello di definizioni linguistiche, la “prostituta” dallo “psicoterapeuta”, e di come sia difficile – nella prassi – distinguere quando una terapista sessuale può essere definita tale, e quando è invece una prostituta. Di fatto, Master e Johnson riferiscono non solo di aver usato a lungo delle o dei Partner sostitutivi – personale cioè incaricato di avere relazioni sessuali con dei pazienti in trattamento psicoterapico – ma di avere anche utilizzato, a tal fine, delle prostitute – stipendiate dalla clinica in cui i due sessuologi lavoravano.
La lettura del volume di Szasz (Szasz, 1982) è in questo senso profondamente illuminante quanto diabolicamente esilarante: altrettanto imponenti i dilemmi che tale problematica suscita (Pasini, 1982), (Pasini, 1990) e altrettanto inquietante il rilievo che se nessuno si sia mai chiesto cosa distingue una “Terapista Sessuale” da una “prostituta”, né quale sia l’autorità etica, scientifica, o legale che possa stabilirlo (De Gregorio, 1994).
A mio avviso, esiste una grande e grave rimozione in tal senso: dato che ogni scuola psicoterapeutica si sente autorizzata a dibattere solo le alternative interne alle proprie teorie e alle proprie prassi, o a negare in toto la validità delle altre teorie, è facile ignorare che il dilemma presentato da queste terapie apre di fatto una crepa incolmabile nell’assunto secondo il quale ogni processo psicoterapico sia identificabile nella teoria attraverso cui il terapeuta dichiara di operare. In altri termini, in psicoterapia è facile creare una teoria di riferimento, e dire di applicarla con fini psicoterapeutici; a rovescio, mancando per così dire una coscienza epistemica negli psicoterapeuti, le discussioni all’interno dei praticanti di ogni teoria sono, come abbiamo visto per il nostro “Rosenhan al contrario”, sempre inerenti alla fedelta con cui la teoria viene applicata.
Riprendendo il discorso sulla sessualità in psicoterapia, occorre qui ricordare come esso sia da sempre un argomento presente in modo spinoso nelle cronache degli studi psicoterapici. Ma mio avviso la sua spinosità emerge perché l’importanza della sessualità nella nostra cultura crea, nel suo incrociarsi con la psicoterapia, l’evidenza che il nucleo ancora irrisolto della psicoterapia non è tanto nella specifica problematica dei rapporti sessuali tra terapeuta e paziente, ma nel perché non si discuta sulla impossibilità a discutere, in psicoterapia, tra ciò che è psicoterapia e ciò che non lo è:
“Infrazioni al tabù psicoanalitico dell’incesto ce ne sono da che c’è la psicoanalisi … il tabù dell’incesto viene infranto in misura inimmaginabile. In base alle nostre ricerche, né in Germania né altrove esiste un solo istituto psicoanalitico con un minimo di storia alle spalle in cui non si mormori per filo e per segno di rapporti sessuali tra analisti e analizzande, e tra gli uni e le altre nel corso dell’analisi didattica. … Joëlle Augerolles, l’autrice di “Mon analyse et moi”, domanda durante una seduta col suo analista, che ha cominciato con lei una relazione sessuale già dopo le prime sedute, se tutto ciò sia consigliabile per l’analisi o invece la danneggi.
Risposta dello psicoanalista: -In questo campo non vi sono regole” (H.S. Krutzenbichler, H. Essers 1993, pag. 118)
Il sesso e le regole del gioco
Nello stesso video in cui si narrava della “Psicoterapia Multidimensionale”, venivano anche raccontate le vicende (peraltro solo metaforicamente espressive della realtà dell’interprete) di una giovane prostituta, tal Katia.
Grazie ad un curioso equivoco, accadeva che costei, presentatasi allo “psicoterapeuta” del video per una consultazione che avrebbe dovuto avere il fine di “migliorare la sua comunicazione col cliente” (e qui vi era un velato accenno ad un certo uso della psicologia a fini commerciali) , veniva scambiata dal terapeuta per una “collega” psicoterapeuta venuta ad offrire la propria collaborazione.
Nel video, la parte di “Katia” era interpretata da una ragazza estremamente intelligente che nella vita proclamava il suo bisogno d’amore e d’amare in nome di una solitudine nella quale si intrappolava cercando di uscirne. La sua “soluzione” consisteva nel buttarsi a capofitto in rapporti affettivi illusorii, creati attraverso una sovrabbondanza di offerte affettive e sessuali, che strutturavano un “contesto” che a lei sembrava di “vero amore”, ma che risultava sempre molto pesante per chiunque le si avvicinasse. La ragazza, che sviliva così il suo potenziale affettivo, ricevette la proposta di impersonare appunto una prostituta al centro di una confusione tutta “epistemologica” e “comunicazionale” circa gli “scambi affettivi”: un “ploys” che in realtà metteva in discussione quanto in psicoterapia si potesse vendere – al di fuori di un proprio impegno etico – un rapporto umano che si fondi su quelle dimensioni affettive che spesso sono rivendicate appunto dai professionisti che operano nel campo come qualità senza cui non si può fare psicoterapia.
Nel film, la confusione tra Katia e lo psicoterapista si genera per l’uso di linguaggi e concetti per qualche verso sconcertantemente in comune, dal momento che entrambi parlano di “incontri a pagamento” e, insieme, di “relazione d’amore” -, di “rapporto intimo e autentico ” ma anche di “professionalità”, di “pagamento fisso” e, insieme, di “condivisione della propria intimità”.
Nel video, tale confusione viene di colpo chiarita quando la ragazza – e, significativamente, non lo psicoterapeuta – comprende che l’altro non ha proprio capito nulla, perché più chiuso di lei nel suo considerare le sue spiegazioni dell’altro come le uniche possibili. Ma quando Katia comunica al “terapeuta” tale scoperta, l’ineffabile “medico” riesce a capovolgere anche questa crisi in soluzione decidendo gioiosamente di aprire un’idonea “Sezione Terapie Sessuali” nello studio, con tanto di “Terapista Sessuale – Partner Sostitutiva”, dichiarando con un candore spudoratamente confondente che lui offriva a una donna disperata l’avvallo della scienza per redimere il proprio inferno.
La vicenda in questione termina, nel video, con la decisione della giovane prostituta di iscriversi a Psicologia, per diventare – diceva – una “vera” psicologa (e il video quasi sottintendeva invece che sarebbe rimasta una “vera psicologa” solo se fosse rimasta una “vera prostituta”) mentre la sua interprete riprendeva a considerare il valore che ella apportava comunque nei rapporti umani.
Ma l’episodio narrato – specie pensando al fatto che le Terapie Sessuali con “Partner Sostitutive” esistono davvero – è destinato a suscitare più di un’ulteriore riflessione. Insieme ad altre esperienze con cui ogni psicoterapeuta è venuto, in un modo o “nell’altro” a conoscenza, apre infatti lo spunto a diverse domande sulla psicoterapia. Ne affronto alcune tratte dalla mia casistica clinica.
Una ragazza, con forti problematiche di inibizione sessuale, si reca in analisi (tendenzialmente ortodossa) presso un grande “psicoterapeuta”, uno psichiatra del Nord. Dopo qualche mese di sedute, il professionista comincia a farle delle avances sessuali più o meno esplicite. La ragazza resiste e il professionista tenta sempre più di vincerne la resistenza e sedurla. E’ sposato, ma la sua corte diventa incessante e incalzante. Seduta dopo seduta, sembra veramente volersi produrre in mille follie pur di poter iniziare una relazione affettiva e sessuale con quella persona che sembra averlo stregato. In breve, arriva a prometterle di separarsi dalla moglie e di sposare lei.
Ovviamente, tutto questo avviene nelle sedute che i due compiono regolarmente nello studio del professionista.
Dopo mesi di tale assedio, la ragazza decide di accettare le offerte dell’analista, e prima di recarsi alla seduta settimanale gli telefona. Gli comunica che si è decisa ad accettare la sua corte, e gli chiede che deve fare il giorno dell’appuntamento: se lei ne diventa l’amante, gli chiede, deve andare alla seduta e pagarla lo stesso?
Il professore le fa presente che sta partendo per un Convegno in Germania e che tornerà dopo una settimana. Le dice di richiamarlo al suo rientro.
La ragazza richiama dopo una diecina di giorni, ricorda al professore che è sua intenzione accettare il suo corteggiamento – specie tenendo a mente i suoi propositi di una separarsi e poi sposarla. Gli chiede quando possono incontrarsi, e gli rinnova la domanda: le sedute e i relativi pagamenti sono ovviamente sospesi ?
La risposta è agghiacciante: – Che ci vediamo a fare, se non vuoi pagare le sedute ? –
Da quel giorno lui le impedisce qualsiasi contatto e lei, disperata, si fa trasferire l’anno dopo in un’altra città.
L’episodio narrato mi è stato riferito da una mia paziente, cui l’ha riferito la ragazza in questione. Per quanto mi riguarda, però, il problema non è – a mio avviso – nella sua veridicità, bensì nella sua possibilità: -In questo campo non vi sono regole” disse appunto lo psicanalista-amante a Joëlle Augerolles. Ed è questo il punto: un episodio del genere può accadere tranquillamente.
Tempo fa una mia “paziente” mi raccontò quanto accadutole anni prima, nella cittadina del Centro Italia ove vive. Recatasi da uno psicoterapeuta (che si professava di “impostazione sistemica”) , aveva cominciato con lui delle sedute individuali. Dopo un anno circa, anche il marito aveva cominciato a frequentare lo studio del professionista in questione – praticando sedute settimanali disgiunte da quelle della moglie.
Dopo qualche mese di terapia, la donna – ancora giovane – si innamorò follemente dello psicoterapeuta. Il professionista ricambiò immediatamente, e i due iniziano uno strano menage: si incontravano regolarmente una volta alla settimana nel suo studio, trascorrendovi il tempo di una seduta, ma passandola da amanti. Non si vedevano mai all’infuori dello studio, anche se la donna, notevolmente innamorata del professionista, lo avrebbe voluto. Il menage terminò cinque anni dopo, mentre il marito della signora ancora frequentava le sedute dello psicoterapeuta.
Per riprendersi dal trauma subito, la signora decise di recarsi in cura presso un altro psicoterapeuta, questa volta in una città vicina. Lo scelse fra i più anziani e rinomati del luogo.
Costui, appena seppe del decorso della precedente terapia, non esitò a scagliare i suoi strali e i suoi anatemi contro il collega, spingendo addirittura la signora a una denuncia contro il criminale.
Ovviamente, questo non gli impedì, nel giro di dieci sedute, di tentare anche lui di sedurla. Insistette non poco, al di là delle velate allusioni, e – sempre più pesantemente – provò a vincere le resistenze della donna. Costei, sconvolta, abbandonò anche questa terapia, e decise di rivolgersi al professionista della grande città. Dalle Pagine Gialle (sulle quali sono presente senza alcuna pubblicità) ottenne il mio indirizzo.
Il suo racconto mi risultò in qualche modo perturbante: l’anamnesi delle precedenti terapie sembrò farne una “paziente” in qualche modo bersagliata dai desideri dei colleghi. Troppo, appunto: e il particolare delle “Pagine Gialle” mi faceva in qualche modo insospettire. Indubbiamente, non era il modo migliore per garantirsi un professionista di cui avere pienamente fiducia.
Nel giro di un paio di mesi, la donna cominciò a ripetere sovente che lei non ci trovava nulla di male nella relazione sessuale fra il terapista e la “paziente” , e che il problema semmai è nel modo con cui viene “agita”. Nel giro di un altro mese, mi sembrò porre in atto qualche atteggiamento seduttivo: le gambe un po’ più esposte del solito, qualche calza a rete che a me apparve un po’ più ostentata di quanto non sembrasse suo costume nei primi tempi, un po’ di scollatura un po’ più scollata di prima. Dopo qualche settimana ancora, la signora mi ripetè – come al solito – che il suo matrimonio era una tragedia, che odiava il marito, che la loro vita sessuale era inesistente. Ma aggiunse chiaramente una frase: che non le sarebbe dispiaciuto avere rapporti sessuali anche con me.
Ignorai la cosa con un mezzo sorrisetto e nel giro di un mese, lei divenne l’amante dell’anziano Direttore Generale della ditta in cui lavorava.
Abbandonò così la terapia, e senza saldare il conto delle ultime quattro sedute. Quasi c’è veramente da dire: il servizio non era stato all’altezza.
Come detto, non posso giurare sulla veridicità del primo episodio: ma – come appunto già accennato – a mio avviso non è lì il vero problema: il problema è che episodi del genere sono possibili, tutti sappiamo avvengono con una certa frequenza, e non sono mai oggetto di “studio”. Sono rarissimi gli articoli e relativi a tali aspetti della pratica professionale, anche se è notorio che vicende del genere hanno da sempre percorso la storia della psicoterapia.
E’ noto (Carotenuto, 1978) che uno dei primissimi scandali relativi ad una relazione sessuale fra una “paziente” ed il suo psicanalista fu quello relativo alla vicenda fra C. G. Jung e Sabina Spielrein. La donna, probabilmente una persona con tratti schizoidi, venne portata nel 1904 in cura da Jung e, poco più che ventenne, ne divenne in breve tempo “paziente” , amante, – e – grazie all’intensissimo sentimento che aveva ispirato in Jung – musa ispiratrice. E’ probabilmente a lei che si deve una delle formulazioni più intense e originali di Jung – quella dell’Anima, il nucleo di esperienze emotive che risiede in ogni essere umano di sesso maschile, che ne rappresenta i tratti “femminili” – sentimenti, affetti, emozioni – e che si presenta nei sogni sotto forma di donna.
Come detto, lo scandalo per la vicenda fu enorme, ma un ulteriore scandalo si ebbe allorché Carotenuto – con uno scoop abbastanza emblematico – pubblicò appunto i documenti che dimostravano inequivocabilmente come il suo capostipite teorico avesse avuto inequivocabilmente almeno una – o due, dal momento che Barbara Hannah ci parla anche della relazione fra Jung e Toni Wolff (Hannah, 1978) – relazione amorosa con una sua “paziente” .
In seguito alla pubblicazione del libro, Bettelheim (Bettelheim, 1983) dichiarò esplicitamente che Carotenuto aveva tentato di nascondere la natura sessuale della relazione fra Jung e la sua “paziente” , la cui esistenza sarebbe incontrovertibilmente comprovata dal carteggio “triangolare” fra Sabina Spielrein, Jung e Freud. In questo carteggio, Jung ammette comunque “le colpe che ho commesso” e dice che il suo “agire è stato una bassezza”.
A dire di Carotenuto, invece, “non esiste una sola evidenza nel materiale pubblicato e nelle lettere di Jung in mio possesso che rapporti sessuali ci siano stati” (Carotenuto, 1983, pag. 118 e segg.). Sta di fatto che la relazione ci fu, fu intensa e esplicitamente ammessa da entrambi come innamoramento, e terminò allorché una lettera anonima – alcuni dicono: scritta da Emma, la moglie di Jung – avvertì la madre di Sabina della cosa. Ne sortì un piccolo scandalo, ben presto soffocato, in cui è emblematico il punto di vista di Jung: in una lettera alla madre egli sostiene che egli smise di tenere in disparte i sentimenti perché non si sentiva impegnato come “medico”, nella relazione con la ragazza, e non si sentiva impegnato come medico per un motivo ben preciso.
La lettera di Jung alla madre della ragazza è in tal senso illuminante, e a mio avviso è un enorme errore leggerla dando una valutazione di Jung in termini morali. Letta infatti da una angolazione moralistica, essa ci appare frutto di una bassezza che è di difficile comprensione. Se invece scartiamo l’importanza che ha “il sesso” nella nostra cultura, e trattiamo l’argomento a prescindere da tale peso – possiamo trovare nelle frasi di Jung domande quantomeno inquietanti.
Egli infatti, rispondendo alla madre della ragazza, disse:
“non mi sentivo impegnato come medico non avendo mai preteso un onorario. E’ quest’ultimo che segna chiaramente i limiti ai quali è sottoposto il medico. Lei capirà che è impossibile per un uomo e una ragazza avere alla lunga soltanto rapporti d’amicizia, senza che ad un certo punto subentri qualcosa. Ma in fondo cosa potrebbe impedire ai due di accettare le conseguenze del proprio amore ? Un medico e la sua “paziente” invece possono parlare di qualunque intimità per un tempo illimitato, e la “paziente” può aspettarsi dal medico tutta la cura e l’amore di cui ha bisogno. Il medico però conosce i suoi limiti e non li varcherà mai, perché è pagato per la sua fatica. E questo gli pone la necessaria limitazione. Pertanto, per rimanere nella posizione di medico come lei desidera, Le propongo di fissare un adeguato onorario per le mie prestazioni. In questo modo Lei sarà assolutamente sicura che io rispetterò in ogni circostanza il mio dovere di medico. Come amico di sua figlia, invece, si dovrebbe lasciare al destino quello che succederà, perché nessuno può impedire a due amici di fare quello che desiderano. Spero, cara e stimata Signora, che Lei mi capirà e comprenderà che in tutte queste cose non c’è alcuna bassezza, ma solo l’esperienza e la conoscenza di sé. Il mio onorario è di Fr. 10 per consultazione.” (Carotenuto, 1978, pag. 104).
L’altro aspetto interessante di questa vicenda è in quel che Bettelheim (Bettelheim, 1983) ci dice circa i “metodi terapeutici” utilizzati da Jung. Nella sua già citata polemica con Carotenuto, Bettelheim (Bettelheim, 1983), così conclude un suo intervento:
“Quale che possa essere il giudizio sul comportamento di Jung verso la Spielrein, probabilmente la sua prima “paziente” psicanalitica, non si può trascurare la sua conseguenza più importante: egli la guarì dal disturbo per cui era stata affidata alle sue cure. Retrospettivamente, dovremmo chiederci: quale prova convincente abbiamo che si sarebbe raggiunto lo stesso risultato se Jung si fosse comportato con lei nel modo che dobbiamo aspettarci da un terapeuta coscienzioso ? Per quanto opinabile possa essere da un punto di vista morale il comportamento di Jung – per quanto possa essere stato eterodosso e disdicevole – in qualche modo ha assolto al primo dovere del medico nei confronti del “paziente” : quello di guarirlo. Certo, a causa del modo con cui fu curata la Spielrein pagò un alto prezzo in termini di infelicità, confusione, disillusione, ma dopotutto ciò si verifica spesso con i malati mentali gravi come lei. Può essere una buona cosa che la storia della Spielrein ci ricordi che, contrariamente alla nostra ottimistica convinzione di saper curare psicologicamente persone molto malate, ci sono più cose in cielo e terra di quanto ne sognino le nostre filosofie” (Bettelheim, 1983, pag. 115).
Sintetizzando le posizioni di Jung e quelle di Bettelheim, sembra che il primo dica che la psicoterapia è caratterizzata solo dal suo essere un rapporto a pagamento. Curiosamente – e mi si perdoni se quel che dirò appare blasfemo verso Jung, ma è in realtà un tentativo di mostrare la luce che a mio parere egli voleva accendere con tale discorso – curisosamente, egli sembra operare come fosse una prostituta che inverte i termini del mestiere: lo psicoterapeuta offre incontri ma si fa pagare per non andare a letto con la “paziente” .
Bettelheim sembra apparentemente andare da un’altra parte, e dice qualcosa che può apparire ignominioso, di cui nessuno solitamente parla: si chiede se si può curare una malattia mentale anche con i rapporti sessuali fra “psicoterapeuta” e “paziente”.
Il sesso come rivelazione e rilevazione
Il punto allora è, secondo me, in una domanda su questa domanda di Bettelheim.
Partiamo da un dato che mi sembra curioso: in nessun punto del carteggio tra Jung, Freud e la madre della Sabine, lo svizzero rivendica l’efficacia che il rapporto fra lui e Sabine Spielrein ebbe per Sabine Spielrein. In nessun punto, cioè, lui si difende con uno dei migliori argomenti a sua disposizione, portando quelle considerazioni che, circa settanta anni dopo, porterà appunto Bettelheim – allorché afferma che, qualunque cosa accadde fra Jung e Sabine, fu questo “qualcosa” a guarire Sabine. Ovviamente, ciò non vuole affatto dire che per Bettelheim la psicoterapia non sia impegno etico e professionale, e che a suo parere la relazione sessuale vada introdotta in psicoterapia. Siamo solo noi che dobbiamo porci – come suggerisce lui – fra cielo e aria.
Rivolgendoci appunto una domanda sulla domanda, questa: dobbiamo discutere se tutto ciò che può avere un effetto positivo sulla “psicopatologia” possa essere utilizzato e definito come psicoterapia ?
In questa logica, se un paziente migliora bevendo un bicchiere d’acqua insieme al terapeuta, nasce – e le cinquecento e oltre psicoterapie esistenti al mondo lo dimostrano – la Terapia del Bicchiere. Che, come il nostro “Rosenhan al contrario” dimostra, verrebbe di sicuro presa in considerazione. Le nostre premesse esplicative potrebbero poi convincerci, a seconda dei casi, che essa è una “vera” psicoterapia o – al contrario – che agisce solo per un “effetto placebo”, dimenticando però che il placebo in psicoterapia non esiste. L’estrema raffinatezza sarebbe poi – secondo me – arrivare a sostenere che non è il Bicchiere, a curare, ma la relazione. Senza spiegare cosa mai stiamo spiegando con il concetto che a curare non è appunto il bicchiere ma la relazione.
Tornando un attimo al rapporto fra sesso e psicoterapia, non è inutile ricordare, come già detto, che le cronache e la storia della psicoterapia sono piene di vicende relative a relazioni sessuali fra analisti e pazienti: oltre a Jung, dovremmo citare Ferenczi – che prese addirittura in analisi la sua amante Gizela, e, successivamente, ebbe una relazione sessuale con la figlia di costei, Elma, dopo però che anch’essa era entrata in analisi con Ferenczi (H.S. Krutzenbichler, H. Essers 1993); non si contano poi i sospettati: Stekel, Reich (che interrompeva le analisi perché si innamorava delle pazienti e ci si metteva insieme), e via dicendo.
Ma, proprio analizzando il tema da un altro punto di vista, occorre anche ricordare come sia evidente a tutti che una relazione affettiva intensa, positiva e gratificante, della quale fanno ovviamente parte i rapporti sessuali, possa avere un influsso positivo su quella che definiamo “malattia mentale”.
Diventa dunque una psicoterapia ?
Il problema ritorna quindi al chiedersi se si possa fare “psicoterapia” con qualunque attività umana – ivi compresa la sessualità – che sembra faccia star bene “l’altro” di una relazione, o se invece possa e debba esistere una sola psicoterapia – concretizzata in una sola prassi psicoterapeutica. Ogni altra ipotesi è infatti esclusa a priori: stabilire che possano esistere solo tre o quattro psicoterapie valide riporterebbe il problema al punto di partenza.
Il dilemma mi appare irrisolvibile – come le infinite discussioni in proposito dimostrano: e a me sembra dunque opportuno cercare la risposta proprio mettendo in discussione la suddetta alternativa. Chiedendosi dunque se non vi sia un livello nel quale, al di là della discussione sulla prassi e sulla teoria “più efficaci” – possa definire qual è il confine tra la “psicoterapia” e ciò che non lo è.
Ritorniamo dunque a Jung: nella sua lettera alla madre di Sabine, lo svizzero metteva bene in luce come il confine della psicoterapia non sia nella prassi, perché la prassi della psicoterapia, asseriva implicitamente nella sua lettera, è il rapporto umano in quanto tale. Ciò che definiamo “psicoterapia” ha quindi – in tale logica – i propri confini all’esterno della propria prassi, e Jung identificava tale confini nella retribuzione economica.
Credo si possa tranquillamente dire – proprio utilizzando il linguaggio jungiano, che mentre Jung diceva ciò stava parlando la sua Ombra: è facile infatti controbattere non poche obiezioni, specie deontologiche, alla sua asserzione. Ma se la si approfondisce per il suo versante “luminoso”, l’assunto di Jung esprime l’idea che il senso della psicoterapia sia nell’impegno professionale dello psicoterapeuta: dunque in un intento, non in un fare. Dal momento che tale intento è un impegno a operare non per il proprio interesse e soddisfacimento ma per il bene dell’altro, ciò vuol dire che tale impegno è un impegno etico.
Ed è qui, a mio avviso, che il problema del sesso in psicoterapia diviene differente da ciò che ci appare sia. Se nella nostra cultura e civiltà l’atto sessuale non avesse questa importanza – ma fosse, ad esempio, sacrale il bere acqua in compagnia – noi discuteremmo qui su quanto sia lecito bere insieme al paziente.
Il che apre appunto una curiosa riflessione: nella teoria del setting ortodosso, si discute anche sulla opportunità di eventi di tale livello: se stringere la mano al paziente, se farlo bere, come dirgli buongiorno, e via dicendo. Nel setting non ortodosso, tutto ciò non è importante. Nemmeno la sessualità, dunque, deve diventare fonte di eccessivi scrupoli ?
Il punto è che nella nostra cultura – in quello che Maturana definisce il nostro “conversare” – la sessualità dà comunque un’impronta indelebile ad ogni relazione: la trasforma irrevocabilmente e trasforma le aspettative e le definizioni che ciascun partner dà di sé e della relazione. Per rientrare in una metafora, avere dei rapporti sessuali non è come bere un bicchiere d’acqua – anche se sembra lapalissiano dirlo. Il problema è invece che spesso, e proprio per il particolare gioco della “psicoterapia”, sembra lapalissiano “farlo”.
Il punto è, allora, riconoscere che il discutere della sessualità in psicoterapia è importante non per il moralismo e lo scandalo che può suscitare tale problema, ma perché è un discutere su quanto possa essere drammatico non definire mai se la psicoterapia è prassi, teoria, o etica.
In questo senso, questo è un discorso che ci permette di prendere in considerazione anche ciò che in altro modo non vedremmo.
In tema di sessualità e terapia, Rappaport riporta un parere di Bliszsten che a mio avviso è estremamente illuminante per sciogliere tale nodo: “Blizsten nota che nel transfert l’analista è visto come se fosse il genitore, mentre nell’erotizzazione del transfert come quando è davvero genitore. Il “paziente” non è neppure in grado di ammettere o di riconoscere il come-se” (Rappaport, 1956; cit. in: H.S. Krutzenbichler, H. Essers 1993 pag. 95).
Il punto secondo me nodale è in questa impossibilità di esperire il “come-se”: una impossibilità che andrebbe peraltro ridistribuita nell’interazione “paziente” -analista, ovvero contestualizzata nel contesto psicoterapeutico: “Con Helen Silverman, nel 1988, è di nuovo una donna a tentare di togliere ai suoi colleghi analisti maschi la paura di una donna vogliosa, infantile-libidinosa, che non conosce limiti. La Silverman rifiuta l’espressione “transfert erotizzato”. Per lei questo è una forma estrema di transfert erotico che da questo si distingue nella forza e nell’intensità del desiderio. La percezione e la forza dell’intensità del desiderio, come a ragione nota la Silverman, dipende dalla personalità dell’analista, dal suo indirizzo teorico, e infine da quel che in questo contesto è chiamato controtransfert. Quel che l’analista accoglie e vive nell’un “paziente” come una forma adeguata di amore di transfert, in un altro “paziente” avverte come esagerato, inopportunamente molesto e patologico” (H.S. Krutzenbichler, H. Essers 1993 pag. 99)
Ammettendo dunque che il problema del transfert erotizzato è un problema di regole di una interazione (secondo la Silverman viene definito tale quando l’analista lo definisce tale), mi sembra fin troppo emblematico questo episodio: “Già nel 1936 Ludwig Eidelberg descrive l’amore di transfert tra una analista e il suo analizzando. Dopo essersi affaticata a lungo vanamente per significare al “paziente” il carattere di transfert dell’amore da lui nutrito, per convincerlo dell’ “irrealtà” e del “carattere di ripetizione” di detto amore, la psicoanalista ricorre a un mezzo assai energico. Si dichiara disposta a separarsi dal marito per contrarre un nuovo matrimonio con l’analizzando. Reazione del “paziente” : si spaventò a morte, respinse recisamente la proposta, e dovette ammettere di essersi convinto” (H.S. Krutzenbichler, H. Essers, 1993 pag. 100).
La soluzione data dalla donna al proprio “paziente” – una soluzione apparentemente paradossale – ci permette oggi di comprendere la natura del problema – che non è in ciò che emerge dalla interpretazione del transfert, ma nella sua contestualizzazione.
Ritornando dunque all’episodio raccontato già nel 1936 da Ludwig Eidelberg, possiamo ben dire che quel che la terapista fece fu di calare la richiesta del “paziente” in un contesto molto “realistico” e “concreto”: è da esempi come questi che emerge come la psicoterapia abbia una natura transcontestuale, molto simile al gioco, e che la sua capacità terapeutica risieda in tale natura: “qui avanziamo l’ipotesi che i paradossi simili a quelli del gioco siano un ingrediente necessario di quel cambiamento che chiamiamo psicoterapia. In effetti la somiglianza tra il processo terapeutico e il fenomeno del gioco è profonda: ambedue avvengono all’interno di una cornice psicologica limitata, limite spazio-temporale di una classe di messaggi interattivi; tanto nel gioco quanto nella terapia i messaggi stanno in una relazione speciale e peculiare con una realtà più concreta e basilare. Proprio come lo pseudo-combattimento del gioco non è combattimento reale, così lo pseudo-amore e lo pseudo-odio della terapia non sono amore e odio reali.” (Bateson, 1972, pag. 233). Più oltre, Bateson usa la metafora dei due amici che giocano a canasta e – dopo aver condiviso le regole del gioco – cominciano a discutere come cambiarle.
In altri termini, la dimensione transcontestuale del gioco sarebbe una caratteristica dei contesti definiti psicoterapici e sarebbe la caratteristica in grado di garantire la trasformazione delle regole con cui vengono create le regole della relazione (Bateson, 1972).
Ciò equivale a dire che nel momento in cui si arriva al rapporto sessuale fra paziente e terapista la dimensione transcontestuale viene di fatto distrutta, perché la sessualità ha un significato molto forte nel definire la relazione. Paradossalmente, potrebbe pure esistere il caso in cui la paziente (o il paziente) si giovino di una tale relazione, ma ciò non potrebbe impedire la distruzione della transcontestualità del processo psicoterapico e, di conseguenza, non potrebbe impedire che il o la paziente iniziasse a definire in modo contraddittorio sia la relazione, sia la coscienza di sé che emerge dalla relazione.
Per utilizzare una metafora legata al gioco inteso in senso ricreativo, ciò vuol dire che andare a letto col “paziente” equivale a tentare di fare la spesa andando al supermercato con i soldi del Monopoli.
Il punto è che nulla impedisce che due giocatori di Monopoli sviluppino transazioni finanziarie “reali” durante una partita di Monopoli, o che si vendano fra loro immobili e beni del valore di miliardi sulla base di transazioni effettuate con i soldi del gioco (noi li definiremmo “matti”, loro si definirebbero “giocatori accaniti”) ma il punto è che tale denaro vale solo all’interno della loro relazione. Ma nella dimensione della psicoterapia, le transazioni non hanno un segnacontesto altrettanto “concreto” dei soldi del Monopoli, il cui dominio d’esistenza è chiaramente distinguibile dal dominio del denaro “reale”.
Quel che voglio dire è che nella scienza dell’oggettività, tra il denaro del Monopoli e quello della transazione economica “reale” v’è una differenza che la scienza dell’oggettività definibile come “oggettiva”. I “soldi” del Monopoli sono nessi di una serie di relazioni in una dimensione transcontestuale, ma la loro differenza con il denaro “reale” ci appare oggettiva. In realtà, per la Biologia della Conoscenza quel che avviene è il poter distinguere esplicitamente i rispettivi domini di esistenza: un “gioco”, per i soldi del Monopoli, la “realtà” per quelli “veri”. In realtà siamo noi come osservatori che creiamo questa differenza, ma questa differenza è poi definita, dalle nostre definizioni, come esplicita e, soprattutto, oggettiva .
La stessa cosa non può avvenire per quanto riguarda i nessi delle relazioni – i sentimenti, gli affetti, le emozioni – quando avvengono in una dimensione di “gioco” come la psicoterapia.
Nella scienza dell’oggettività, i sentimenti messi in gioco in un contesto sono gli stessi di quelli messi in gioco in una dimensione transcontestuale: possono essere “spiegati” come motivati da istanze differenti (ecco i concetti psicoanalitici di “transfert”, “proiezione”, “controtransfert”) ma la loro natura è descritta e percepita come identica a prescindere dal contesto in cui emergono: “amore”, “amicizia”, “psicoterapia”.
Da questo punto di vista, la scienza dell’oggettività è conseguentemente incapace di distinguere efficacemente tra il dominio di esistenza della coppia “paziente – psicoterapeuta”, e il dominio di esistenza in cui questa opera, che è il dominio di interazione dei due individui che creano la relazione definita come “psicoterapeutica”. Ciò comporta che la transazione affettiva emergente in questo dominio di domini appare attribuibile indifferentemente alla coppia “paziente/psicoterapeuta” quanto a quella degli individui che la compongono, e che hanno dato vita a questo gioco di distinzioni. Diviene dunque sempre più difficile esperire questo distinguere il distinguere, e poiché l’autocoscienza emerge dalla relazione in atto in questo contesto, e dunque da questa possibilità di continuare a operare attraverso queste distinzioni, un segnale molto forte quale è la sessualità crea – in virtù dei significati che ha nella nostra cultura – una distorsione continua della autocoscienza dei partecipanti alla relazione.
Occorre qui considerare che ciò che definiamo spazio psicologico – quella che chiamiamo “la vita psichica, mentale o spirituale, ha luogo nello spazio di relazione dell’organismo” (Maturana, 1997, pag. 198) e “inoltre, dal momento che il linguaggio come dominio di coordinazioni comportamentali consensuali è un fenomeno sociale, anche l’autocoscienza è un fenomeno sociale che non avviene entro i confini anatomici della corporeità dei sistemi viventi che la generano. Al contrario è esterno ad essi e riguarda il loro dominio di interazioni come una maniera di coesistere” (Maturana, 1993 pag. 95).
Ma l’importanza di affrontare il problema della sessualità nel processo psicoterapeutico non è solo relativo alle distorsioni coscienziali che ne emergono (la relazione che si genera è affettivamente valida quanto, appunto, l’acquisto di una casa coi soldi del Monopoli), ma anche perché evidenzia come la scienza dell’oggettività non possa spiegare i confini della psicoterapia. Detto in altri termini, tale problema segnala, per utilizzare una metafora della VMT, che – se si tenta di definire attraverso l’oggettività il confine della psicoterapia – il rischio cui si va incontro è quello di entrare nello sfruttamento dei sentimenti altrui o nella prostituzione.
Il vero problema, però, è che a mio avviso tutta la psicoterapia si fonda su questa possibilità di creare confusioni tra nessi di relazioni, dai quali emerge l’autocoscienza e dunque la possibilità di trasformarla nel gioco che si crea.
Conseguentemente, la soluzione non può essere nel definire – attraverso l’oggettività – quali sono la prassi o la teoria “esatte”, perché la prassi e la teoria sono strumenti, e quel che definisce l’atto psicoterapeutico in quanto tale è il suo intento etico. In altri termini, occorre pensare alle prassi e alle teorie sulla mente come a strumenti attraverso i quali si interviene nella relazione con l’altro: il loro uso è nel loro fine. Ad esempio, sebbene meno eclatanti dei casi di relazioni sessuali in psicoterapia, i casi di “sfruttamento” economico di pazienti da parte di psicoterapeuti non sono meno significativi (anche perchè tendenzialmente pi pubblicizzati) di quelli nei quali la moneta di scambio che viene “scambiata” e dunque cambiata – se ci si passa il gioco di parole – è la sessualità: il problema non è dunque nel tipo di nesso che viene confuso. Per restare nella metafora del Monopoli, nei casi di sfruttamento economico da parte dello psicoterapeuta verso il paziente, il denaro che fluisce da questi al suo “curante” viene “percepito” dal paziente come se appartenesse ad un dominio nel quale la distinzione tra soldi “finti” e soldi “veri” non ha importanza, mentre lo psicoterapeuta rimane consapevole della distinguibilità e sovrapponibilità dei relativi domini di esistenza (tra quello cioè in cui i soldi considerati “veri” sono da considerarsi “veri”, e i soldi “finti” sono da considerarsi invece “finti”).
Questo implica che compito dello psicoterapeuta è un compito incredibilmente colmo di responsabilità: dare un senso etico ad un mondo che, osservato e descritto attraverso una logica dell’oggettività, si dimostra invece un mondo nel quale “non vi sono regole”.